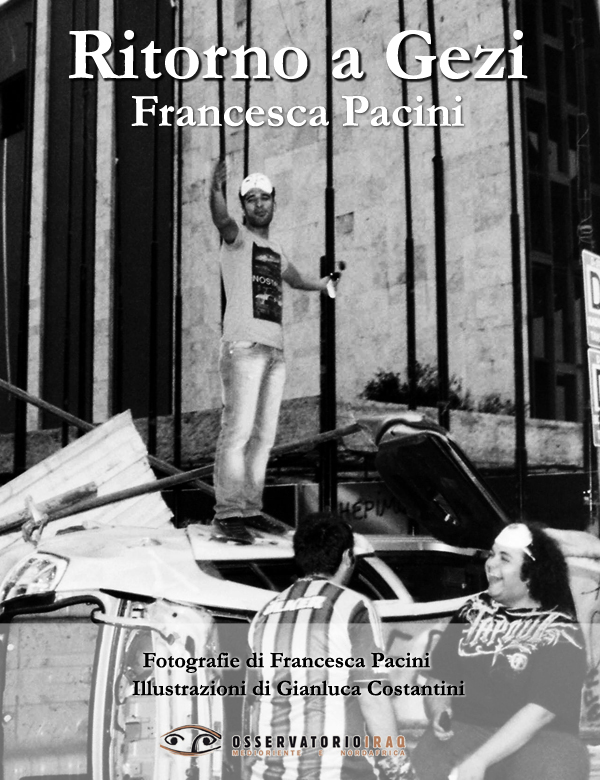Marocco, i volti dell'anima.
Il nuovo reportage narrativo e fotografico
“Quale campo tendato preferisci, Francesca? Quello con i comfort o quello selvaggio?”
“Quello selvaggio, Faysal...
Leggi tutto …
Presentazione de La mia istanbul
L'11 Aprile, a Roma.
Da Gezi Park alle elezioni, si raccontano Istanbul e la Turchia.
...
Leggi tutto …
Turchia, Gezi Park: Il mio nome è Ali Ismail Korkmaz
Si chiamava Ali Ismail Korkmaz. Aveva solo diciannove anni e implorava i suoi assassini di smetterla, ma loro continuavano a massacrarlo di botte. Era il 2 giugno 201...
Leggi tutto …
Istanbul, il "caldo" weekend di Piazza Taksim
“Internetime dokumna!”, “Don’t touch my internet!”. Questo lo slogan che ha chiamato a raccolta, sabato scorso a piazza Taksim, centinaia di manifestanti. ...
Leggi tutto …
Turchia, Gezi Park: giustizia per la "ragazza in rosso"
Il suo nome è Ceyda Sungur, studentessa. E' diventata famosa, suo malgrado, durante i giorni della resistenza di Gezi contro le imposizioni del gover...
Leggi tutto …