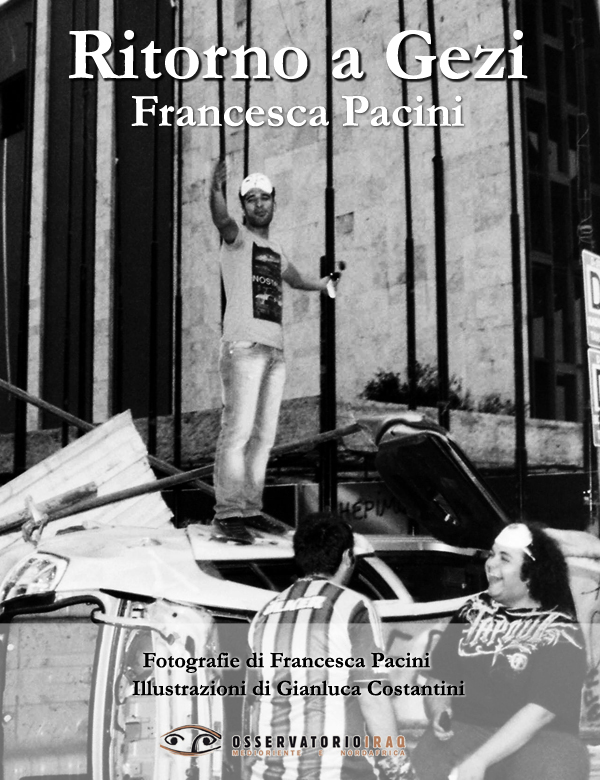A Istanbul, da Galata a Taksim. Soprese dietro il vecchio tram.
7 gennaio 2014
C'è un vecchio tram, che collega Galata e Taksim, dal sapore retrò. Racconta di tempi passati e di antiche suggestioni. In mezzo alla folla di Istik...
Leggi tutto …
Istanbul. Capodanno a Taksim? No grazie.
2 gennaio 2014
E’ così bella, Istanbul, di notte.
Mentre osservo le luci, vicine e lontane, la pioggerella che batte si trasforma quasi in una carezza. “Neanch...
Leggi tutto …
Istanbul e la malinconia invernale
Quando si pensa a Istanbul, si immagina, di solito, il tramonto che incendia il Bosforo, sullo sfondo delle moschee. Non tutti sanno che, in realtà, d'inverno Istanbul �...
Leggi tutto …
Istanbul, a colpo d'occhio
17 dicembre 2013
Spesso, quando vado a Istanbul, le persone mi chiedono "Ma come ti trovi?", "Come si sta lì?".
Quasi dovessi andare in una cittadella popolata da un...
Leggi tutto …
Reportage: Ritorno a Gezi
29 novembre 2013
Esce oggi, per Osservatorio Iraq, il mio reportage: "Ritorno a Gezi "
i
La protesta, il racconto di alcuni protagonisti, gli abusi della polizia, ...
Leggi tutto …